 Da ieri un’altra coppia di amici indossa un simbolo di unione all’anulare sinistro.
Da ieri un’altra coppia di amici indossa un simbolo di unione all’anulare sinistro.
Ecco, quando io penso “che bella, la fede”, qualcosa stride.
Come dire, ogni volta che utilizzo la parola “fede” in chiave positiva, un filosofo muore.
Ma procediamo con ordine. Sparso.
Non amo abusare del termine “amico”. Troppo vago, indefinito, forse addirittura buonista. Definire il posto che Rodolfo occupa nella mia geografia relazionale, poi, è ancora più complicato.
Di quelle facce che vedi da una vita, che incroci tante volte e che ti danno un qualche buon retrogusto, forse un po’ evanescente, ma familiare, fragrante. Di quelle persone che sai perfettamente chi sono, cosa fanno e come la pensano (perché in paese ogni segreto appartiene a Pulcinella), ma che sono distanti, perché appartengono ad un altro mondo, vicino ma impermeabile. Poi succede che il destino ti regala quel paio d’ore, in cui l’evanescenza si fissa nella complicità, in cui il piacere di ri-conoscersi prende il sopravvento su tutto.
Ecco, tra me e Rodolfo è andata così.
Chi, come me, ha molte conoscenze ma usa con molta cautela il termine “amicizia”, accoglie gli incontri particolari con entusiasmo ma tende a gestirli con estrema attenzione e parsimonia. Un po’ è il desiderio di non “consumare” troppo velocemente, tipo quelli che mangiano lentamente una pietanza buona; un po’ per sana scaramanzia. Piano, Hagi. La fortuna va rispettata.
Ecco, con Rodolfo non è andata così.
Cioè a dire: immagina una telefonata di due ore, in cui tocchi temi diversissimi tra loro, tra il sacro e il profano, il serio e il faceto, l’impegnato e il becero. Due ore in cui ti sembra di parlare con uno che non solo conosci da una vita, ma che ha camminato attraverso le stesse esperienze (e non è accaduto), gli stessi luoghi (e non è accaduto), gli stessi problemi pratici (nemmeno). Durante le due ore (che sembrano dieci minuti), un’unica spiegazione: gemellaggio astrale: tipo, due fratelli in un’altra vita, due persone legate da un qualche cazzo di filo che si ritrovano a dire:
vabbeh, mo’ è meglio che attacchiamo
e poi, giù altri quaranta minuti intrisi di letteratura, storia locale, dinamiche sociali, arte, musica e dichiarazioni di guerra alla mediocrità.
Quello che cerco di dire, è che Rodolfo è entrato nella mia vita improvvisamente, pure se è impossibile non vedere che tale perentorietà ha in sè qualcosa di pre-caricato. Per me la presa di coscienza che lui esista è stato un regalo del destino, di quelli importanti.
Sapere che Rodolfo si sia sposato con Luana, è un doppio regalo. Perché – se non mi sono del tutto rincretinito, e ancora riesco a capire un minimo le persone – loro hanno un legame profondo, laddove per “profondo” intendo qualcosa di stratificato, meditato, concordato. Lo si capisce da tante cose: dal rispetto reciproco che hanno per gli spazi altrui; dal controllo, discreto e amoroso che hanno l’uno nei confronti dell’altra e viceversa; dall’apertura della discussione, che va palesemente al di là di facciate o di manierismi. Quando Rodolfo ha bisogno di un punto di vista alternativo, è da Luana che va. La loro è una coppia vera, e il saperli sposati dà linfa alla mia debolissima fiducia verso il futuro del genere umano. Il saperli sposati mi rende allegro, perché secondo il mio modesto parere, finché alchimie del genere saranno possibili, ci sarà sempre speranza.
Ok, ‘sto tono da profeta de’ noàntri è stucchevole. Ma non è a voi che deve piacere. E poi questa non era che un’untuosa introduzione al tema vero del post:
IL MATRIMONIO DI RODOLFO E LUANA
Prologo:
A Roma imperversa una guerra civile a causa di una partita di calcio. A Gallese nessuno ne sa niente, ma imperversa ugualmente una guerra civile. Si pensa ad un’annessione di Gallese a Corchiano sulla falsariga dell’anschluss del 1938, ma i guerrieri – pur determinati nel loro proposito e arringati ferocemente da ‘Ttrombone, sono troppo ubriachi per dar seguito al progetto. Decideranno quindi di limitare l’azione alla demolizione di un convento francescano che ha retto per sette/otto secoli, con eventuale profanazione del camposanto attiguo.
—-
Sabato, mattina
Non va bene. Troppi corchianesi, e troppo vicini ai palazzi del potere. Rodolfo l’aveva detto:
ce saranno 250 corchianesi, tutti lì intorno. Potrebbe essere la volta buona!
Arriviamo col Maggiolone fin sotto la chiesa, e parcheggiamo in un posto che ci sembra il migliore possibile. È un po’ sulle strisce, ma non ostacola passaggi ed è la prima macchina dell’eventuale corteo. In più i cani sono sono all’ombra. Saremo pronti a scortare gli sposini con la Bacarozza tirata a lucido.
Salendo le scale, incrocio visi noti e meno noti, alcuni fumano, altri vanno a prendere il caffè, altri ancora assistono alla funzione. Più donne che uomini.
Vedo la capoccia di Rodolfo accanto ad un velo di tulle d’altri tempi. Attendono alla cerimonia compitamente in fondo alla navata centrale della bella chiesa; Moneti e io siamo in ritardo, manco a dirlo. Mancini e Nenci sono i primi ad essere incontrati. Il primo sfoggia una tenuta a metà tra il cameriere di albergo e un giocatore di NBA in libera uscita, il secondo un orecchino che pare quello requisito a Maradona dalla guardia di Finanza. Moneti rimane alla funzione, io esco in preda all’orticaria, nonostante l’omelia del prete – centrata sull’amore universale – sia stata condivisibile e di buon gusto.
È la prima cerimonia seria corchianese cui assisto. Alcune cose meritano di essere appuntate. La prima sono i vestiti: pare di stà in un non-luogo collocabile tra una festa di miliardari australiani e a un fidanzamento dei Casamonica. I maschi sfoggiano gessati anni trenta, spezzati arditissimi o completi che vanno dall’azzurrino Lazio 92’/93′ al salmone sushi; le femmine stanno tirate come cime di una barca a vela, truccate, acconciate e fasciate da vestiti cerimoniosi; tutte modelle o attrici, salvo il fatto che vengono impietosamente tradite dalle loro andature basculanti e incerte sul tacco dodici, e dalle buste contenenti sneakers di ricambio. Tutto concorre a rendere l’atmosfera gagliarda, esuberante.
L’uscita degli sposi è sfolgorante. Luana sfoggia un vestito bellissimo (nessuno avrebbe mai dubitato del contrario): è di un color crema sobrio e delicato, impreziosito da merletti e ricami raffinatissimi. Rodolfo è stato vestito da Luana (non mi pare che me l’abbia detto, ma mi ci gioco un cane), ed è slanciato e moderno.
Vengono bersagliati festosamente dal riso, e intanto ci si muove per organizzare il corteo.
L’amara constatazione.
Dopo pochi metri, ci coglie una visione raggelante: un enorme camion con i morsetti della batteria, piazzato davanti alla mia macchina e di fronte all’uscita del parcheggio. Risultato: risate e ritardi. E qualche bestemmia, poche.
Partiamo senza che nessuno o quasi abbia potuto godere dei frutti dell’olio di gomito e della pasta abrasiva sulla carrozzeria di Bacarozza, coperta dal camion.
Arriviamo a Gallese, e scopriamo che il numero civico di via di S. Francesco coincide con gli alberi pizzuti. Momento di riflessione su legame tra vita e morte, poi buffet. Fritti. Pesce. Salumi. Formaggi. Pizzette. Prosecco. Piattini di cuscus. Piccole zuppiere di moscardini. Momento di amore con frittata di tartufi (e fraternizzazione con sconosciuti). Starei a posto fino a cena, ma sta per iniziare il pranzo, alle 16:30.
Il nostro tavolo, “Lavanda”, è composto da coppie. Si urla e si strepita. Si battono i pugni sui tavoli. C’è un’allegria nell’aria che è commovente. Niente a che vedere con la cerimoniosità gratuita che ho visto altrove. Qui, quando si festeggia, tutti tornano ad avere l’età giusta per farlo: 15 anni. Il vino è buonissimo (ma molti corchianesi non apprezzano: da queste parti è spesso l’odore di cantina che rende un vino più o meno buono), e comunque scorre a fiumi. I più sono ubriachi già al secondo primo. Sberna accusa il bianco come un destro sul mento, e pare apprezzare. Trombone sta morendo dissanguato; paga il sacrificio di essersi fatto la barba per il matrimonio. In tutto ciò, Moneti ed io facciamo avanti e indré con la macchina per far scavallare le Pipidi, ospiti d’onore gestite anch’esse – come l’amicizia – con parsimonia.
Insomma, ci si diverte, c’è convivialità.
Passare attraverso i tavoli sembra un viaggio nel tempo. Ci sono almeno 4 generazioni di corchianesi contemporaneamente. Nonni che rinascono in nipoti, prima di morire. Poi c’è Germano, che le suddette generazioni le ha viste crescere tutte e 4, probabilmente.
Per me – la cosa interesserà poco – questo matrimonio è un viluppo di sensazioni contrastanti. Alterno leggerezze a gravità, riflessioni e perdite di coscienza. Io non faccio parte di questo mondo, e nonostante tutti i miei sforzi mai potrò appartenervi. La mia condizione di mezzo sangue si mischia con una perfida situazione di eradicamento, per cui io non sto mai a casa mia, anche se sono di casa in molti posti. Figurati a Corchiano.
Vedo Eugenio, e realizzo che lo conosco da quando lui era molto più giovane di me. Vedo Germano, e ricordo il suo Sì rosso. Quando guardo lo Streppo, in testa gli vedo ancora i ricci, a Sandro la frangetta. Eppure, ed è così da quando sono piccolo, ho un “peccato originale”, di quelli che non dipendono dalle azioni, ma dal karma. Io non appartengo a questo posto appieno, anche se l’ho unilateralmente eletto a “patria immaginata”, perché le mie radici non sono qui. Forse, se mai ne avrò, i miei figli potranno sentire il paese un po’ loro, perché saranno “fiji de uno chesse conosce”. Ma mentre preparo loro il terreno migliore che posso (con alterne fortune), vivo tra le pieghe di una condizione “di mezzo”, e mangio e bevo con persone con cui sono cresciuto senza avere con esse una vera e propria familiarità. È bellissimo, caldo e rassicurante, ma sento addosso un conflitto perenne, un senso di “fuori luogo”, acuito dal vedere Mario Ppassone perfettamente lucido.
Alterno momenti di comunione completa con altri in cui mi chiedo cosa stia facendo. Trovo abbracci veri in persone lontane, e convenevoli formali con persone vicine. Parlo di un passato remoto e condiviso con persone di cui conosco la faccia, ma non il nome.
Su tutto questo veglia il gesto teatrale, misurato e calcolato di quel vecchio, giovane amico mio, che nella mia mente sarà sempre al centro della scena, brandendo una bottiglia di Fernet e dispensando massime di antica sapienza contadina, inframmezzate da qualche citazione latina. Magari bucolica. Anzi, Georgica.
L’ultima impressione forte, per Luana: come tutte le persone che hanno le idee chiare, sembra severa, e forse in parte lo è. Ma, vi prego, osservatela quando saluta i bambini: se avete gli occhi in testa, vi si potrebbero inumidire.
***
Torniamo a casa alticci ma non sbronzi, dopo una serata magnifica, in cui tutto ha funzionato a meraviglia. La corchianesità l’abbiamo solo assaggiata: sono sapori forti, e vanno saputi gestire. Per fare le 5, ci vuole tempo, forza e un’abitudine ancestrale a farlo. Come la garra del Fernet.


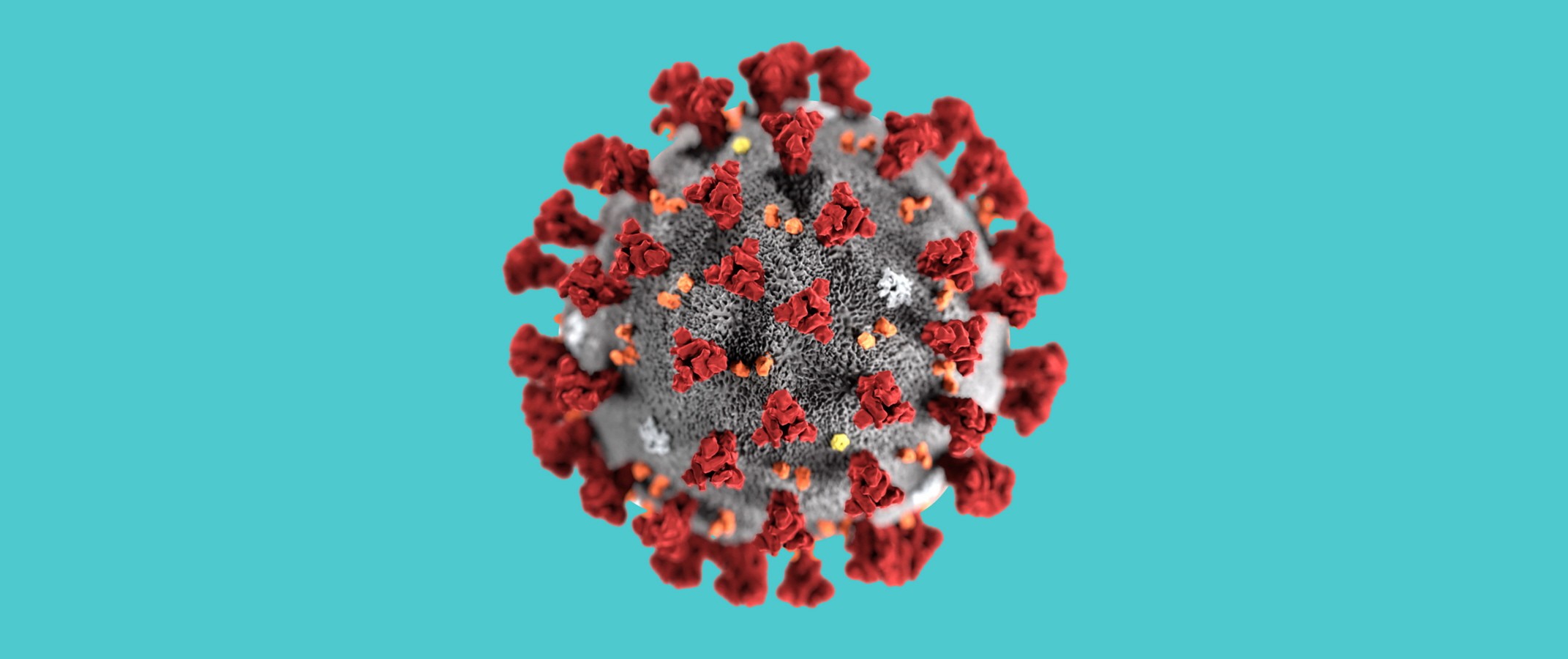



Scrivi un commento